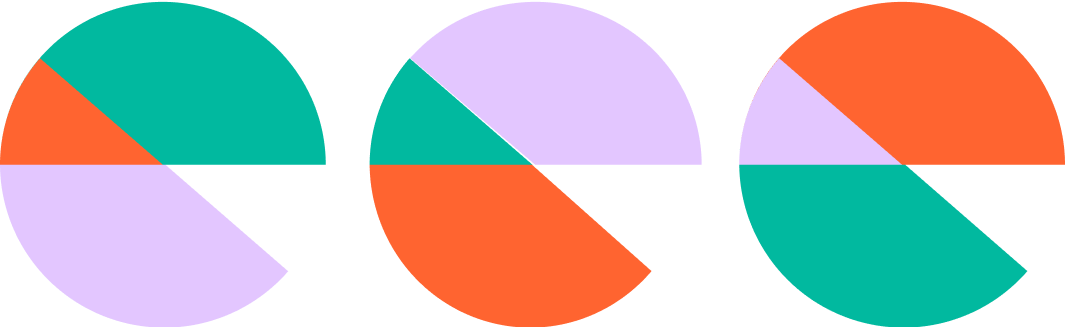Le crisi contemporanee – economiche, sociali e ambientali – incidono in maniera profonda sul nostro modo di vivere e di abitare gli spazi del quotidiano. Negli ultimi decenni la società ha attraversato cambiamenti radicali. L’innovazione tecnologica ha introdotto strumenti e forme di interazione inedite, che hanno modificato la percezione comune di spazio e tempo. Le trasformazioni maggiori hanno visto il radicamento della diffusione del lavoro a distanza e delle piattaforme digitali che hanno rivoluzionato modalità, forme e spazi lavorativi, favorendo la comparsa di contesti alternativi a quelli tradizionali. La trasformazione degli spazi di lavoro in un’ottica di riduzione e smateralizzazione dell’ufficio, avviata già prima della pandemia, è una delle principali ricadute della diffusione del lavoro remotizzato (Bassanelli Forino, 2021). Contestualmente, le persone si sono ritrovate a lavorare da casa – senza però avere sempre le condizioni per ricreare soluzioni adeguate alle attività lavorative – spesso dovendo gestire una sovrapposizione spaziale tra attività produttive e riproduttive (Borgia, Palermo, 2021).
È in questo scenario che il progetto architettonico diventa strumento e fine di una ricerca che ha come caposaldo l’integrazione tra la sfera lavorativa e quella legata alla cura. Attivato in seno al progetto di interesse nazionale (PRIN2022) “ESCAPES – Soluzioni spaziali sperimentali per la gestione sostenibile di lavoro a distanza e cura familiare”, il workshop “Carespaces” mira alla costruzione di una strategia progettuale che fornisca come esito nuovi spazi di lavoro condivisi e integrati alla scala del quartiere che rispondano al loro interno e nella parte di città in cui si collocano, anche a esigenze di cura e di socialità, a partire da una riqualificazione di spazi dismessi, pubblici e privati.
Il progetto ESCAPES ha evidenziato come manchi nello scenario abitativo attuale una riflessione che comprenda, prima di tutto, la capacità del luogo di lavoro, esterno all’ufficio, di accogliere spazi che rispondano ai bisogni della persona nella gestione della vita quotidiana e, in parallelo, delle considerazioni efficaci sulle opportunità di rifunzionalizzare i numerosi spazi vacanti che sempre più caratterizzano i piani terra degli edifici residenziali o ad uso misto esistenti. Questi ultimi, quali spazi di soglia tra pubblico e privato, possiedono il potenziale di attivare nuove forme di vicinato e vita comunitaria, soprattutto nelle aree urbane densamente popolate dove è in aumento l’esigenza di ambienti flessibili e accessibili. Immaginare tali luoghi per funzioni condivise –come il lavoro a distanza, l’assistenza o i servizi di quartiere – significa concretizzare suddette potenzialità rendendoli elementi connettivi all’interno del tessuto urbano.
Gli studenti della Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni e della Scuola di Design del Politecnico di Milano e della Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari si sono cimentati nel compito, operando sul complesso delle Gallerie Ormus, progettato dall’architetto Giulio Minoletti e realizzato tra il 1963 e il 1967 nel quartiere San Benedetto a Cagliari. Si tratta di cinque palazzine disposte a pettine unificate da un basamento comune a doppia altezza che costituisce una “piastra” pubblica dedicata a uffici, attività commerciali e ristorative e caratterizzata da patii e gallerie. La tipologia spaziale è quella della galleria urbana di derivazione ottocentesca dai passages che Walter Benjamin ha descritto nel celebre testo Das Passagen-Werk (1982). Soffermandosi su tale zoccolo ed analizzando lo stato attuale di incuria in cui versano le gallerie, emerge la percezione di uno spazio che non ha mai trovato una forma e una funzionalità compiuta, lasciando l’interno urbano in uno stato di incertezza. Questo contesto complesso e stratificato ha offerto l’occasione per un ripensamento critico delle modalità di trasformazione e reinterpretazione di questi spazi, ponendo attenzione non solo alla loro qualità architettonica, ma anche alla loro capacità di evocare e rielaborare le dinamiche storiche, sociali e culturali che li attraversano. L’approccio degli studenti mira alla riattivazione del piano terra delle Ormus, attraverso la sua trasformazione in cerniera pubblica che ricuce le torri residenziali al quartiere. Le gallerie, da corridoi inerti e degradati, diventano infrastrutture di relazione che collegano spazi di lavoro e di cura atti a riconnettere domesticità e urbanità. Se in “ottica sociale” l’obiettivo è ridurre lo scarto quotidiano tra sfera produttiva e riproduttiva, offrendo servizi che semplificano le attività di cura, nella prospettiva architettonica la strategia è offrire spazi multifunzionali accomunati dal principio di permeabilità, flessibilità e accessibilità. Ne scaturiscono “microluoghi” che, oltre a restituire continuità alle gallerie, rendono la “piastra” un dispositivo civico intergenerazionale capace di innescare pratiche collettive autogestite e di vicinato.
Il progetto di architettura è concepito, quindi, non più come produzione di uno spazio statico, ma come costruzione di uno spazio dinamico, capace di evolversi in relazione alla dimensione temporale della vita quotidiana, o del “tempo reale” (Bassanelli 2024). Si assiste così a un passaggio da una visione tradizionale, fondata sulla definizione di ambienti stabili e permanenti, a un approccio più flessibile e adattivo. Gli spazi non vengono più intesi come forme concluse, ma come sistemi in trasformazione, pronti a modificarsi in base ai ritmi della quotidianità e alle esigenze mutevoli degli individui.